Qual è il valore di un giorno? Un estratto di Tra le pieghe dell’orologio
Scrivere un diario può essere l’occasione per dire tutta la verità. Così è per Heidi Julavits: scrittrice, madre, moglie, modello di identità autoriale al femminile. Pubblichiamo l’incipit di Tra le pieghe dell’orologio, nella traduzione italiana di Gabriella Tonoli e nell’orginale inglese. Questo libro «splendido… Un’opera tanto intelligente da sembrare priva di artifici» (The New York Times Book Review) è disponibile in tutte le librerie. Buona lettura!
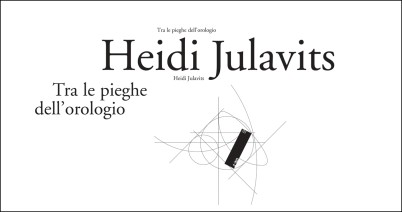
Oggi mi sono chiesta, Qual è il valore di un giorno? Una volta, un giorno era lungo. C’era la luce e poi non c’era più; si mangiava, si andava a scuola, forse si faceva sport, e due giorni dopo ci sarebbe stato un test, o una tesina di inglese da consegnare, o una festa che aspettavo – sembrava – da anni. I giorni erano secoli. In un giorno l’amore sbocciava e moriva. La rabbia divampava, era dimenticata e poi rimpiazzata con una nuova rabbia, anch’essa subito dimenticata. Nell’arco di un giorno c’erano ore ben scandite e orologi con lancette che macinavano ogni nuovo minuto. Mi veniva da pensare, Finirà mai questo giorno? All’imbrunire, avevo la sensazione di aver combattuto una guerra. Ero ferita; il sonno non bastava a guarirmi. I giorni si sedimentavano nei nervi, registrando scosse di assestamento. I giorni avevano un impatto fisico. I giorni potevano far male.
Ora non più. Il “giorno” non esiste più. L’unità di tempo più piccola che riconosco è la settimana. Ma negli ultimi anni anche la settimana, come il penny, è diventata una valuta inutile. In generale, l’unità di tempo più piccola che riconosco è il mese. Ma in verità neanche i mesi sono così facili da distinguere. I mesi si succedono più rapidi quando siamo in debito di qualcosa. Le tasse, l’affitto, l’assicurazione sanitaria. Un mese non è segnato dalla sensazione che il tempo sia passato, ma da una serie di addebiti automatici. Do un’occhiata al conto in banca, prosciugato, e capisco, deve essere marzo.
Dato che, a quanto pare, sono diventata dieci anni più vecchia rispetto a un anno fa, ho deciso di tenere un diario. Come tanti, da piccola tenevo un diario. Ho cominciato a scriverlo a partire dall’età di otto anni, tutti i giorni, e tutti i giorni la mia annotazione cominciava con “oggi”, seguito da un’azione che mi vedeva protagonista. Oggi sono andata a scuola. Oggi sono andata a casa di Andrea. Oggi ho giocato al cimitero. Oggi non ho fatto nulla.
Di recente, per parlare della ragione per la quale sono diventata una scrittrice, ho accennato a questo mio diario d’infanzia. Dovevo spiegare a un’aula piena di gente, perlopiù sopra i settant’anni, perché. Avrei potuto rispondere alla domanda in svariati modi. Ma cerco di prevedere le esigenze del mio pubblico. È mio desiderio fornirgli un aneddoto ad hoc che entri in forte risonanza con le loro vite; più che la verità, è questo desiderio a motivare le mie risposte. Cosa voleva sentire o aveva bisogno di sentirsi dire questa gente? Se fossi, come loro, al tramonto della vita, credo che sarei insofferente verso qualsiasi ambiguità e incertezza. Vorrei storie chiare, immagino, se fossi a un passo dalla tomba, ridotta a un nome, una data, qualche virgola, una categoria (“moglie”).
Così ho raccontato una storia lineare. La storia del perché. Ho raccontato di essere diventata una scrittrice perché un giorno di marzo, all’età di dieci anni, durante l’interminabile fine del tipico inverno del Maine, grigio dopo grigio, mio padre mi portò al centro commerciale, visto che avevamo ormai esaurito i modi di ammazzare il tempo in attesa della primavera. Comprò un televisore a colori. Per certi aspetti, pratici ed emotivi, l’acquisto aveva senso. Il nostro vecchio televisore era in bianco e nero. Per scegliere i due canali e mezzo disponibili ruotavamo uno spuntone di metallo (una volta coperto da una manopola, poi andata persa) con una pinza. L’antenna originale (persa anche quella) era stata rimpiazzata da una gruccia. L’intero congegno era così patetico e di fortuna, e come biasimare un uomo per quel suo tentativo di portare, letteralmente, il colore nelle vite della moglie e dei figli che si trascinavano verso un’altra stagione all’insegna del fango e del disgelo?
Purtroppo, mio padre non poteva permettersi un televisore a colori. Era già successo altre volte che avesse acquistato oggetti che non poteva permettersi, e quindi era sommerso dai debiti. Non avrebbe più potuto comprare nient’altro. Ogni suo acquisto non era autorizzato. Ma questo non gli impedì di comprare il televisore.
Quella volta mio padre mi comprò anche un diario, facendomi promettere che ci avrei scritto. Lo cominciai il giorno dopo. Scrissi: Oggi mi sono alzata e ho guardato la tv.
Più o meno dieci anni fa ho trovato e riletto questi miei diari. Prima di trovarli e rileggerli, la consapevolezza di aver tenuto rigorosamente un diario mi inorgogliva: ero destinata a diventare una scrittrice! Avevo prove della mia ostinazione – svariati volumi di prove. Immaginavo il giorno in cui i diari sarebbero stati pubblicati, quando la mia fama letteraria avrebbe conferito loro un valore artistico e biografico. Ero convinta che il mio destino fosse la grandezza postuma. Spesso mi immaginavo più famosa da morta che da viva.
I diari in sé, tuttavia, non riescono a confermare il mito che avevo architettato per me stessa. Non rivelano la mente di una futura scrittrice, ma di un futuro revisore dei conti paranoico. Non manifestavo alcuna immaginazione né traccia di stile, nessuna arguzia, nessuna personalità. Ogni annotazione è un racconto delle (o un’ansia espressa riguardo alle) mie prestazioni scolastiche.
***
The Folded Clock
June 21
Today I wondered What is the worth of a day? Once, a day was long. It was bright and then it wasn’t, meals happened, and school happened, and sports practice, maybe, happened, and two days from this day there would be a test, or an English paper would be due, or there would be a party for which I’d been waiting, it would seem, for years. Days were ages. Love bloomed and died in a day. Rages flared and were forgotten and replaced by new rages, also forgotten. Within a day there were discernible hours, and clocks with hands that ticked out each new minute. I would think, Will this day never end? By nightfall, I’d feel like a war had been fought. I was wounded; sleep was not enough to heal me. Days would linger in my nerves, aftershocks registered on the electrical plain. Days made a physical impact. Days could hurt.
Not anymore. The “day” no longer exists. The smallest unit of time I experience is the week. But in recent years the week, like the penny, has also become a uselessly small currency. The month is, more typically, the smallest unit of time I experience. But truthfully months are not so noticeable either. Months happen when things are, with increasing rapidity, due. Tuitions are due, and rent is due, and the health insurance is due. A month is marked, not by a sense that time has passed, but by a series of automated withdrawals. I look at my bank account, near zero, and realize, It must be March.
Since I am suddenly ten years older than I was, it seems, one year ago, I decided to keep a diary. Like many people I kept a diary when I was young. Starting at age eight I wrote in this diary every day, and every day I began my entry with “Today I.” Today I went to school. Today I went to Andrea’s house. Today I played in the cemetery. Today I did nothing.
Recently I cited this childhood diary-keeping as the reason I became a writer. I needed to explain to a roomful of people, most of them over seventy years old, why. I could have answered the question in a variety of ways. But I try to anticipate the needs of my audience. I desire to give them an anecdote customized to resonate with their life situation. This desire guides my answers more strongly than truth. What did these people want or need to hear? If I were, like them, nearing the end of my life, I imagine I’d be impatient with equivocation and uncertainty. I imagine I would desire clear stories because soon I’d be in a grave where my life would be condensed to a name, a date, some commas, a category (“Wife”).
So I told a clean story. A why story. I said that I became a writer because on one March day, when I was ten, during the interminable gray-scale finale of a typical Maine winter, my father took me to the mall because we’d long ago run out of ways to kill time before spring. At the mall, he bought a color TV. On certain practical and emotional levels, his expenditure made sense. Our old TV was black-and-white. We switched between the two and a half available channels by using a pair of pliers to rotate a metal stub, once connected to a dial (now lost). The original antenna (also lost) had been replaced by a clothes hanger. The whole contraption was so pathetic and downtrodden, who could blame a man for trying to bring literal color into the lives of his wife and children, emotionally slogging their way through another mud season?
Unfortunately, my father did not have permission to buy a color TV. At an earlier point in time, he’d bought something else without permission, and before that something else, and now he was deeply in permissions debt. He would never get permission to buy anything ever again. Every acquisition was unauthorized. This did not prevent him from buying the TV.
My father also bought me, if I promised to write in it, a diary.
I started the diary the next day. I wrote: Today I woke up and watched TV.
I found and reread these diaries about ten years ago. Before I found and reread them, I was proud of what the fact of my rigorous diary keeping predicted about me. I’d been fated to be a writer! I had proof of my doggedness— many volumes of it. I imagined the diaries published at some future date, when my literary fame might bestow upon them an artistic and biographical value. I believed I was born to posthumous greatness. I often imagined myself more famous when dead than when alive.
The actual diaries, however, fail to corroborate the myth I’d concocted for myself. They reveal me to possess the mind, not of a future writer, but of a future paranoid tax auditor. I exhibited no imagination, no trace of a style, no wit, no personality. Each entry is an accounting of (or an expressed anxiety about) my school performance.

This Post Has 0 Comments