Pubblichiamo l’incipit del romanzo di Simone Marcuzzi
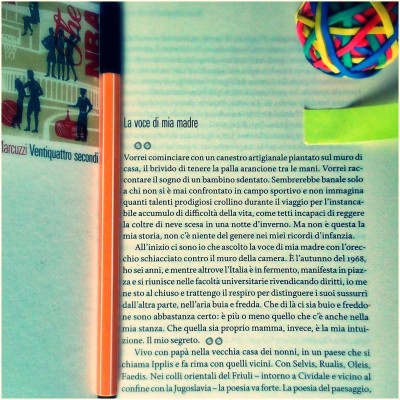
Vorrei cominciare con un canestro artigianale piantato sul muro di casa, il brivido di tenere la palla arancione tra le mani. Vorrei raccontare il sogno di un bambino sdentato. Sembrerebbe banale solo a chi non si è mai confrontato in campo sportivo e non immagina quanti talenti prodigiosi crollino durante il viaggio per l’instancabile accumulo di difficoltà della vita, come tetti incapaci di reggere la coltre di neve scesa in una notte d’inverno. Ma non è questa la mia storia, non c’è niente del genere nei miei ricordi d’infanzia.
All’inizio ci sono io che ascolto la voce di mia madre con l’orecchio schiacciato contro il muro della camera. È l’autunno del 1968, ho sei anni, e mentre altrove l’Italia è in fermento, manifesta in piazza e si riunisce nelle facoltà universitarie rivendicando diritti, io me ne sto al chiuso e trattengo il respiro per distinguere i suoi sussurri dall’altra parte, nell’aria buia e fredda. Che di là ci sia buio e freddo ne sono abbastanza certo: è più o meno quello che c’è anche nella mia stanza. Che quella sia proprio mamma, invece, è la mia intuizione. Il mio segreto.
Vivo con papà nella vecchia casa dei nonni, in un paese che si chiama Ipplis e fa rima con quelli vicini. Con Selvis, Rualis, Oleis, Faedis. Nei colli orientali del Friuli – intorno a Cividale e vicino al confine con la Jugoslavia – la poesia va forte. La poesia del paesaggio, la poesia del linguaggio. Ti sposti di pochi chilometri e la rima cambia in -acco. Premariacco, Remanzacco, Moimacco, Laipacco. Il terreno è sassoso, i greti dei fiumi sono bianchi, ci sono boschi di castagni, valli popolate di streghe, viti a perdita d’occhio. Le viti sono il lavoro di papà. La cantina del signor Crisettig, cui presta servizio da quando ha vent’anni, è tra le più importanti della zona. Esporta bottiglie anche in America. Papà lo dice con orgoglio esprezzo insieme. Perché America è qualcosa di grande, ma gli americani erano contro Mussolini. E lui non è come gli altri friulani, democristiani per paura delle idee. Lui è fascista convinto, perché quando c’era il Duce la gente era più educata, e perché i partigiani rossi hanno ucciso a sangue freddo nonno Enore, che allo sfilacciarsi del regime si era tenuto alla larga dai gruppi organizzati. Chiamarmi Vittoriano è stato il suo atto di fede e il suo augurio: andare oltre la mediocrità dei tanti è l’unico scopo che valga la pena di perseguire in vita.
Quando papà era piccolo nella nostra casa hanno abitato fino a diciotto persone. Assieme a nonna Ester c’erano gli zii e i cugini di papà, e c’era suo fratello, lo zio Franco. Crescendo tutti loro sono usciti di casa per sistemarsi nei dintorni, compresi in un raggio di trenta chilometri. In un primo momento anche papà l’ha fatto, andando in affitto in un appartamento più vicino all’azienda vinicola. Alla morte della nonna si è però scoperto l’unico a non voler vendere. Gli altri concordavano sull’opportunità di liberarsi della vecchia costruzione di famiglia, troppo grande e malmessa. Papà era uno contro tanti, ma era il maggiore e quello con la voce più potente. E aveva un motto: «Se vuoi combinare qualcosa nella vita, devi fare tutto da solo».
